La didattica
Il modello messo in atto al Centrostudi Comunicazione era ispirato al motto di Confucio: se leggi dimentichi, se scrivi ricordi, se fai impari.
Enrico Cogno era solito, in aula, ripetere un esempio: immaginate, diceva agli studenti, che abbiate comprato la vostra prima autovettura; pieni d’entusiasmo avrete letto il libretto d’istruzioni, comprese le indicazioni su come cambiare una ruota in caso di foratura. Vi sarà sembrato tutto chiaro: cric, svitamento dei bulloni, cambio della ruota, ecc. Immaginiamo ancora che abbiate usato l’autovettura per molti anni, senza forare mai: sarà però accaduto che un giorno vi siete trovati con la gomma a terra e avrete cercato di ricordare cosa avevate letto quella volta, scoprendo così di non rammentare nulla. Se invece aveste imparato a cambiare una gomma, voi stessi, in prima persona, sotto gli insegnamenti di un automobilista esperto, lo avreste ricordato senza sforzo per tutta la vita.
L’esempio chiariva il concetto di “apprendimento emozionale basato sull’esperienza”: nel primo caso, la teoria era disgiunta dalla pratica; nel secondo caso era erogata congiuntamente. Non solo: nel primo caso la foratura era solo un’eventualità remota e di conseguenza la motivazione ad apprendere era vaga, teorica; nel secondo caso era reale e la motivazione era elevatissima, anche perché, diversamente, le persone sarebbero rimaste per strada. E’ la stessa cosa, diceva Cogno, che riempire quaderni di appunti su interessanti nozioni sulla comunicazione, per poi scoprire di non saper fare, di fatto, nulla, anche dopo anni di studio con ottimi docenti teorici.
Pedagogia e andragogia
Legare l’apprendimento teorico al momento stesso in cui si ha necessità/desiderio di mettere in pratica quell’insegnamento fu la mossa vincente. Nulla di nuovo, certo: lo si faceva anche nel mondo del lavoro, ma non lo si attuava, chissà perché, in quasi nessuna aula. Il perché è da ricercare nel fatto che, a partire dal medioevo, con il modello delle scuole monastiche, la pedagogia (educazione dei fanciulli) ha preso il sopravvento sull’andragogia, l'insegnamento agli adulti.
Secondo lo studioso americano Malcom Knowles, l’andragogia si basa su una serie di presupposti ben distinti rispetto al modello pedagogico, rivolto all'educazione degli adolescenti. I principali presupposti del modello andragogico indicati da Knowles affermano che l'adulto, per poter apprendere, deve sentire in sé il bisogno di conoscere e si deve sentire rispettato dall'educatore. Il discente deve essere collocato in una situazione di autonomia e non di dipendenza. Nell'educazione dell'adulto ha un ruolo essenziale l'esperienza, sia come attività di apprendimento, sia come pregresso (talvolta negativo) che costituisce una barriera di pregiudizi e abiti mentali che resiste all'apprendimento; quindi l'apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale e le motivazioni più forti sono quelle interne, come le ultime posizioni della piramide di Maslow indicano: desiderio di una maggiore soddisfazione nel lavoro, qualità della vita, auto-stima, ecc.
Anche Carl Rogers e Rollo May, padri fondatori del counseling, hanno illustrato nei loro studi il ruolo fondamentale di una educazione e di un rapporto non valutativo, basato sul dialogo, sull’ascolto e sul rispetto dell’altro.
Ne deriva che gli elementi fondamentali per un corretto processo formativo dovrebbero essere i seguenti:
- Assicurare un clima favorevole all'apprendimento, sia dal punto di vista delle strutture (funzionali e accoglienti), delle risorse (ampie e utilizzabili), dell'organizzazione (funzionale, non gerarchica, comunicativa);
- Deve essere messo in atto un meccanismo che preveda una progettazione comune;
- Occorre diagnosticare i bisogni di apprendimento elaborando un modello delle competenze;
- E’ necessario valutare le discrepanze tra il modello delle competenze e il livello di sviluppo attuale dei discenti, riformulando di conseguenza gli obiettivi di apprendimento;
- Occorre progettare un modello di esperienze di apprendimento, non il semplice "programma" ma un vero e proprio progetto d'apprendimento, fondato su una serie di episodi tra loro correlati;
- Mettere in atto il programma (gestire, cioè, le attività di apprendimento);
- Infine, valutare il programma con un’attenta azione di feedback.
Il modello andragogico era l'approccio tipico dell'ermeneutica greca, quello per intenderci utilizzato da Aristotele, Demostene, Cicerone e dagli altri filosofi che, nell'insegnamento, utilizzavano dei sistemi didattici basati sul dialogo e sulle esperienze pratiche, dal momento che non potevano contare sull'ausilio di libri di testo o sulla possibilità di far prendere degli appunti ai loro studenti, spesso analfabeti.
Le teorizzazioni erano costituite da dialoghi e da esemplificazioni, spesso basate su metafore; largo spazio trovavano anche gli approcci tipici della “didattica attiva”, basati quindi sulla soluzione dei problemi attraverso esperienze pratiche. Il metodo quindi consisteva nell'affrontare le questioni mediante il dialogo, definendo il modo chiaro il problema e facendo proporre ai discenti le possibili soluzioni, in sostanza quello che oggi le scienze manageriali chiamano problem solving.
Si arrivava così alla soluzione del problema attivando lo spirito d'iniziativa dei discenti che apprendevano le nozioni attraverso un sistema basato sulla continua analisi del lavoro in corso d'opera, guidati, quasi senza che se ne rendessero conto, dai metodi illustrati dai docenti.
La conseguenza di questo approccio è la motivazione all’apprendimento: si è molto più interessati a sapere "come si fa una cosa" quando ciò serve a risolvere un problema che si sta affrontando; l'interesse invece diminuisce quando, di questo know how, non se ne vede un immediato utilizzo. Motivare le persone significa metterle nella condizione di voler fare una cosa che non di doverla fare: nell’andragogia trova quindi largo spazio tutto ciò che favorisce l'uso del verbo volere al posto del verbo dovere. Molti anni dopo la fondazione, il Centrostudi Comunicazione organizzò un convegno proprio su questo tema, intitolato “Voglio, non devo”, animato dalla presenza del Prof. Enzo Spaltro.
Si noterà come, nella maggior parte dei sistemi di studio praticati in Italia dalla scuola pubblica, il metodo andragogico sia quasi totalmente disatteso.
Per molti anni sono stati affidati i compiti operativi agli stage aziendali, per tenere ben separate le finalità teoriche da quelle pratiche.
Un simile approccio ha per anni lasciato irrisolta, in Italia, la capacità pratica di affrontare e risolvere sin dal momento formativo i problemi, creando quindi il fenomeno che oggi colpisce la maggior parte dei giovani al termine degli studi: l’incapacità di svolgere un’attività professionale senza un previo periodo di addestramento, che obbliga quindi ad aggiungere tempi di preparazione al non breve tempo dedicato agli studi.
Per modificare la situazione fu chiaro che la parola-chiave di tutto il ragionamento era il rovesciamento del metodo: anziché prima spiegare “come si fa” e poi farlo fare, si trattava di farlo apprendere in corso d’opera, secondo il classico learning by doing, imparare facendo.
Per questo motivo i corsi si chiamavano Master Operativi.
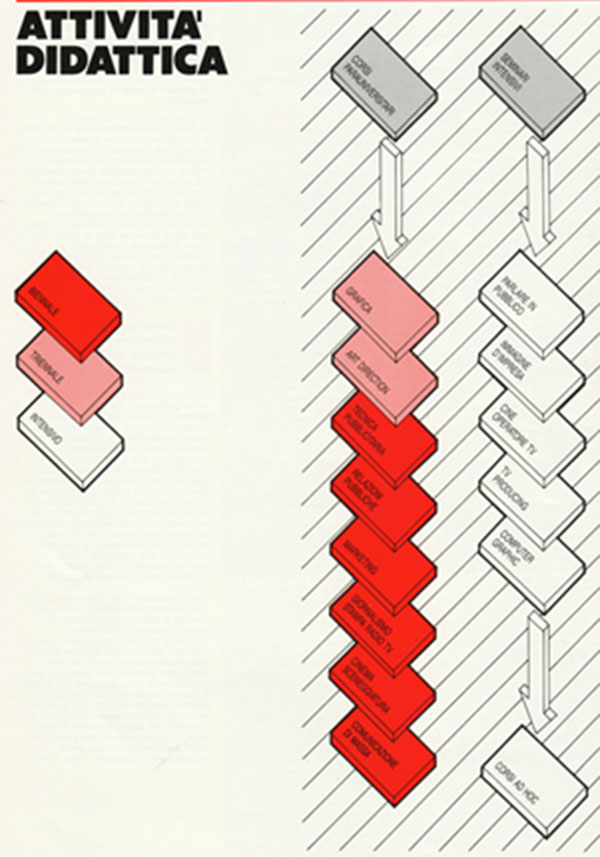 Una scena che sempre sorprendeva gli studenti era la prima lezione del Master, perché non era una lezione: era una seduta di lavoro, di fatto un briefing simile a quelli che si svolgono nelle imprese o nelle riunioni militari prima di una missione. Il brief è un documento programmatico che contiene i dati essenziali di un progetto per la realizzazione del quale sono previsti ruoli e compiti da svolgere.
Una scena che sempre sorprendeva gli studenti era la prima lezione del Master, perché non era una lezione: era una seduta di lavoro, di fatto un briefing simile a quelli che si svolgono nelle imprese o nelle riunioni militari prima di una missione. Il brief è un documento programmatico che contiene i dati essenziali di un progetto per la realizzazione del quale sono previsti ruoli e compiti da svolgere.
Gli studenti, quando capivano che avrebbero dovuto realizzare quel determinato progetto in un ridotto numero di giorni, sbiancavano in volto, sentendosi totalmente incapaci di farlo. I più arditi protestavano: “Ma noi non siamo in grado”. E il docente di turno replicava: “Ma noi fortunatamente si, per cui ci chiedete quello che volete sapere e noi vi mostriamo come si fa, anzi lo facciamo insieme”.
Questa era l’essenza del metodo: avere voglia di ricevere le informazioni, anziché subirle. La lezione-shock iniziale serviva a chiarire che, poiché esisteva un problema da risolvere con urgenza, la salvezza era il poter disporre delle tecniche per risolverlo sotto forma di consigli da parte di esperti.
Agli studenti era richiesta un’assidua frequenza per cinque sera alla settimana, dal lunedì al venerdì, ed un serio impegno: venivano suddivisi in piccoli gruppi, la cui composizione non era casuale e seguiva delle regole precise a seconda della disciplina oggetto del progetto.
Le norme principali erano tre: a volte si consentiva l’aggregazione naturale, per scelta operata dagli studenti. In quel caso, quasi sempre, la scelta avveniva per provenienza regionale, poiché il campanilismo è una solida base aggregante.
Il secondo metodo era quello del sorteggio, per allenarsi a lavorare con chi capita, come nella realtà, dove non ci si sceglie per empatia. Il terzo metodo, quando il progetto lo richiedeva, prevedeva la fusione tra alcune sezioni di differenti master: ad esempio, gli studenti di art direction erano immessi nei gruppi di marketing e viceversa.
Ogni disciplina era assegnata a rispettive organizzazioni leader del settore. A seconda dei tipi di corso, venivano coinvolte nell’erogazione aziende, associazioni del terzo settore, agenzie, gruppi di consulenza, tutte rappresentate dai loro manager (direttori marketing, direttori commerciali, brand manager, responsabili delle ricerche, analisti finanziari, account, direttori creativi, copywriter, art director, responsabili del reparto mezzi ecc.) che guidavano la realizzazione dei progetti esattamente come erano abituati a fare nelle loro attività d’impresa.
D'altro canto, quello di essere buttati immediatamente nella mischia è esattamente quello che è sempre avvenuto nel mondo del lavoro.
Questo metodo forniva due risultati importanti: il primo era l'abbreviazione di tempi di apprendimento, che permetteva di svolgere in modo intensivo un programma molto vasto, da 500 a 900 ore secondo il programma scelto. Il secondo era quello di riprodurre una situazione così simile a quella che si ritrova all'interno degli ambienti di lavoro per cui lo studente, al termine del Master, era in grado di operarvi immediatamente, senza problemi.
Gli esami erano sostituiti dalle presentazioni dei progetti che avvenivano con le stesse modalità in uso nel settore: i componenti del gruppo, completato il lavoro, predisponevano i supporti visivi (a volte con l’aiuto di allievi dei master di graphic design, altre volte autonomamente) e, alla data fissata, illustravano nel tempo stabilito il progetto alla commissione composta dai Manager/Formatori. La valutazione avveniva con la compilazione di schede che prendevano in considerazione tre fattori:
- la correttezza metodologica del progetto;
- l’abilità organizzativa del gruppo di lavoro;
- la creatività espressa.
A questi fattori si aggiungeva il voto sulla capacità espositiva di ogni studente, che faceva media con il voto assegnato al progetto. Era pertanto interdetto il compito di portavoce del progetto, per allenare tutti alle tecniche di public speaking. Ogni studente era tenuto a rispettare l’equa suddivisione dei tempi.
La presentazione dell’intero progetto prevedeva di solito venti minuti: se i componenti erano cinque, ognuno era tenuto a non superare i “suoi” quattro minuti.
Le infrazioni a questa regola, all’inizio molto frequenti, costavano una penalizzazione in termini di voti.
Per allenare gli studenti a queste tecniche di presentazione si ricorreva al metodo definito, dagli anglosassoni, “elevator speech”. La tecnica consiste nell’immaginarsi in un ascensore (elevator) a fianco di una persona che potrebbe essere lo sponsor ideale, una volta convinto della bontà del progetto in questione. Se al termine della corsa, di solito della durata di sessanta secondi, non si è riusciti a convincere l’interlocutore, l’approccio sarà fallimentare.
Il voto ottenuto dal progetto (espresso in trentesimi) entrava a far parte della cartella didattica dello studente. Per alcune discipline che, per loro natura, non si prestavano a una verifica sotto forma progettuale, erano valutate mediante prove scritte che riproducevano situazioni reali. Non esistevano, quindi, esami orali basati su testi da apprendere quasi a memoria: si valutavano, come nel lavoro, l’apprendimento e le abilità apprese, non solo la capacità di memorizzazione di nozioni.
Le molte presentazioni allenavano gli studenti ad essere nell’eloquio efficaci, concreti e autorevoli.
Molte testimonianze affermano che nelle imprese, quando arrivava un manager neo-assunto che presentava con efficacia i suoi progetti, la domanda di rito era: “Ma tu hai fatto il Centrostudi Comunicazione?”.
Alla presentazione dei progetti, che avveniva circa due volte al mese, assistevano come commissari d’esame dei cultori della materia.
Quello che colpiva questi manager era l’autonomia che gli studenti dimostravano, conseguenza del metodo di preparazione basato sia sul “gettare gli studenti direttamente nella mischia” (sebbene assistiti in modo molto stretto dai loro docenti e dai tutor) sia nelle tecniche di elevator speech.
Questo sistema prese il nome, nell’ambiente delle scienze della comunicazione, di Metodo Cogno. Gradualmente, a partire dagli anni ‘80, il metodo venne ripreso da molte altre organizzazioni e, in qualche caso, anche da qualche università.
Centrostudi comunicazione cogno e associati © Enrico Cogno 2018-2026 Responsabile: Enrico Cogno. - Partita IVA 01872310584.
Made with oZone iQ